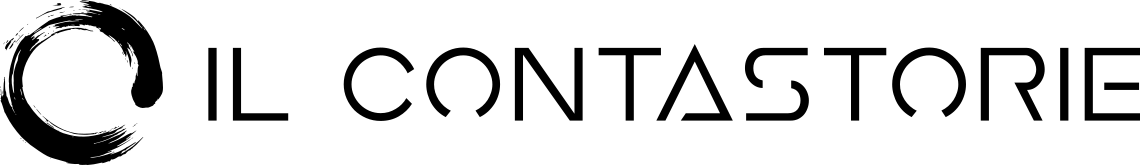Violino
La folla dei mendicanti si aprì per farlo passare. Un Mosè accattone e un mare di straccioni che si spalancava davanti a lui senza nemmeno dover fare un segno con la mano. La custodia del violino gli pendeva dalla spalla: la pelle nera lacera e consunta, le chiusure ossidate, tutto portava il segno del lungo servizio prestato.
Veniva da molto lontano, ma tutti sapevano chi era e lo salutavano chinando il capo con deferenza, senza osare sfiorarlo. Il tunnel sotterraneo sfociava nell’ampio spazio di una stazione della metropolitana in disuso. Seduto su un trono realizzato con un vecchio sedile strappato da un vagone distrutto, lo attendeva il re. Gli si fermò davanti e piegò lievemente il capo, in segno di rispetto. “Mi tratterò per breve tempo nella vostra città. Suonerò agli angoli delle strade.”
Il re fece un cenno affermativo. “Per chi sei venuto?”
“Questo non lo posso dire.” sorrise.
“E sia. Hai libero accesso a tutto il mio territorio, nessuno ti importunerà. Sei sotto la protezione del re.”
Piegò nuovamente il capo in segno di assenso e si allontanò. La folla si aprì nuovamente al suo passaggio. Non aveva bisogno di chiedere il permesso a nessuno, ma provava gusto nel mantenere le tradizioni. E la tradizione voleva che ogni mendicante che entrava in un territorio nuovo si presentasse al re degli straccioni a chiedere il permesso di mendicare.
Risalì in superficie seguito dagli altri mendicanti che si dispersero, ognuno verso il suo luogo abituale. La città odorava di sterco di cavallo e fumo di carbone, ma nemmeno il puzzo delle strade riusciva a cancellare del tutto il dolce profumo della primavera.
Camminò senza meta finché non trovò un luogo che lo ispirasse. Scelse l’angolo di una piazza contornata da palazzi antichi, aprì la custodia e tirò fuori il violino. Il legno lucido, quasi bianco, talmente chiaro da sembrare osso, contrastava con il nero della tastiera. Sistemò la mentoniera, regolò con precisione l’accordatura e passò la pece sui crini dell’archetto.
Quando iniziò a suonare le note penetranti riverberarono sui palazzi antichi creando un’armonia complessa. Il suono sembrava attardarsi, scivolava lungo i muri, inondava la piazza, rimbalzava indietro, indugiava ancora, come non volesse spegnersi.
I passanti si fermavano, colti alla sprovvista e lasciavano cadere qualche moneta nella custodia aperta, affascinati e spaventati dalla musica del suo violino. Suonò a lungo, pezzi famosi e brani dimenticati da secoli, suonò le sue composizioni, suonò brani per quartetto, per orchestra, per solista. Ogni nota volava magica nell’aria e ognuno portava via con se un pezzetto di quella musica e inconsapevole la faceva risuonare nella propria testa, consumando la cena, preparandosi a dormire, attizzando il fuoco nel camino, finché i sogni non la consumavano.
Suonò qualche ora, poi soddisfatto del guadagno cercò una locanda dove mangiare qualcosa e fermarsi a dormire. Lo attendeva un lavoro importante. Il suo lavoro lo era sempre e vi dedicava la massima cura, non gli importava se doveva suonare per un re, un ciabattino, un marinaio, se fosse una sguattera o una regina e richiedere i suoi servigi.
Dormì. Dormì uno spartito in si minore, un adagio complesso e intricato di melodie sovrapposte.
Fece colazione e senza affrettarsi si recò nello stesso angolo del giorno precedente. La notizia della sua musica si sparse per la città. Vennero in molti ad ascoltarlo, appassionati, sedicenti esperti ed esperti veri, vennero bambini, insegnanti, nobili. Solo i mendicanti si tennero lontani, tappandosi le orecchie quando appoggiava l’archetto sulle corde. Attese. Suonò. Non aveva fretta. Colui che l’aveva chiamato sarebbe andato da lui quando si fosse sentito pronto.
Trascorsero alcuni giorni e finalmente, proprio quando stava riponendo il violino nella custodia, lo vide. Capì subito che era lui, lo capì dallo sguardo. L’uomo non disse nulla, si incamminò nell’ombra scesa sulla città mentre ancora ls luce rosata del che ammantava i campanili e le guglie di chiese e palazzi.
Lo seguì, fino a un portone rinforzato da pesanti borchie di ferro nero. Lo seguì nel cortile interno, salì le scale guidato dal suo passo ed entrò nella camera. L’uomo giaceva nel letto, consumato dalla stanchezza di una vita troppo lunga. Non gli disse nulla, un cenno del capo fu sufficiente.
Appoggiò delicatamente a terra la custodia e prese il violino. Con estrema cura verificò la tensione delle corde, le pizzicò appena, lasciandole risuonare nel silenzio della casa. Controllò l’archetto, sistemò ogni cosa con estrema cura.
Sorrise all’uomo che lo guardava dal letto e attaccò un brano in una tonalità inusuale, fatto di note lunghe che si sovrapponevano in dissonanze sincopate per poi mescolarsi in accordi dolci e melodiosi. Una nota alla volta guardò il cuore dell’uomo fermarsi. Con la sua musica guidò la vita fuori da quel corpo consumato. Con un lieve sorriso l’uomo esalò l’ultimo respiro che si attorcigliò all’ultima nota della melodia.
Il violino è morte, è straziante lamento, è dolce riposo, è grido lacerante, è gioia. Il violino è vita, è respiro, è cuore che pulsa, sangue che scorre.
Uscì dalla casa, alcuni mendicanti chinarono il capo vedendolo passare. Senza dire nulla se ne andò dalla città, verso il suo prossimo lavoro, verso il prossimo uomo che aveva bisogno di morire.
Libero Seleni