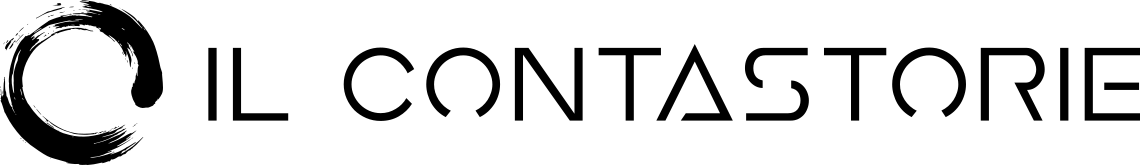Guerra chimica
Usarono i gas. Anche noi li usammo. Da entrambe le parti iniziarono a piovere bombe cariche delle peggiori schifezze. Gas lacrimogeno, cloro, iprite. Dopo settimane nelle trincee, immersi nel fango, nell’interminabile attesa del proiettile che ti ammazzerà, affronti quasi con sollievo il momento di andare all’assalto. Se sei fortunato puoi perfino cavartela e se sei davvero fortunato ti beccherai subito un proiettile in fronte o nel cuore che metterà fine a questa merda. Almeno per te.
Ma i gas sono un’altra cosa. Si insinuano nella nebbia che grava perennemente su questa terra di nessuno, non li vedi, te ne accorgi solo quando è tardi e stai già sputando i polmoni, ripiegato su te stesso come un pugno chiuso, o quando la pelle si lacera in orribili piaghe infette.
Ci fecero indossare le maschere antigas e ci mandarono all’attacco, appesantiti da mantelli cerati. Dovevamo proteggerci dai gas dei nemici, ci dissero. Non ci dissero però che in caso di necessità avremmo usato i gas anche noi. Noi. L’unico gas che usavamo noi carne da macello era quello delle nostre scoregge. Anche il nostro schieramento aveva i gas e li usava contro i nemici. Ma cosa succede quando i nemici sono troppo vicini? Non persero tempo a domandarselo e quando i nemici attaccarono li bombardarono coi gas. Proprio nello stesso momento in cui noi attaccavamo, sotto il bombardamento dei loro gas.
In pochi istanti il campo di battaglia diventò una pianura velenosa, punteggiata da corpi che si contorcevano. Pensai ai lombrichi dissotterrati che cercano disperatamente di ritornare nella terra. Ecco, quelli eravamo noi. Fu l’ultimo pensiero che ebbi quando una granata mi fiorì accanto, scagliandomi in aria e strappandomi la maschera antigas dal volto.
Mi risvegliai. Non avrei dovuto, ero saltato in aria, avevo respirato senza maschera i gas letali, l’esplosione mi aveva strappato di dosso gli indumenti cerati a protezione della pelle. Eppure mi risvegliai. Un crepuscolo insanguinato fendeva la candida nebbia portata dal vento di mare. Faceva freddo, avevo perso uno stivale e la giacca era così lacera da non servire più a nulla. Vagai fra i corpi, presi uno stivale ad un soldato, non so di quale schieramento e la giacca a un altro. A un altro ancora rubai il cappotto, chiedendo ogni volta scusa, anche se a loro non potevano più servire.
Camminai sul suolo pesante, scavalcando i cadaveri, senza sapere dove andare. Tutto era uguale, in ogni direzione nebbia e morti. Udii delle voci, mi avvicinai, un manichino zoppicante che brancola nel niente. “Altolà.” gridò una voce. “Chi va là? Farsi riconoscere.”
Provai a rispondere. Avrei voluto gridare, ma le parole mi morivano in gola. E comunque cosa avrei potuto dire? “Amico?” non sapevo se lo ero o se lo ero stato. Non sapevo da che parte stessero. Non sapevo nemmeno da che parte fossi stato io.
Camminai verso di loro mentre i fucili iniziarono a crepitare. Sentii i proiettili sfiorarmi, li vidi in un sogno al rallentatore volare leggeri nell’aria verso di me. Piccole forme aggraziate, ruotavano su se stessi nel loro volo rettilineo tracciando scie vorticose nella nebbia. Sorrisi estasiato quando mi lacerarono la carne.
Continuai a camminare verso di loro. Gridavano, ma non comprendevo le parole. Non è che non conoscessi la lingua, non capivo il motivo del loro terrore. Mi sentivo leggero. Corsi da loro. Li sfiorai con le dita e li vidi accasciarsi, il loro passo interrotto a metà, crollavano a terra come tuffatori ubriachi.
Camminai ancora, altre voci in lingue diverse mi chiesero chi ero. Non avevo risposte per loro. Non avevo risposte nemmeno per me. Ogni volta mi salutarono con gioiosi proiettili, mi chiamarono a loro. E ogni volta corsi a cercare il loro tocco, a sfiorare le loro dita, a sentire i loro cuori fermarsi. Anelavo il brivido elettrico della loro vita che si dissolve, il momento di estasi che accompagna la fine.
Non sapevo chi ero. Ora lo so.
Libero Seleni